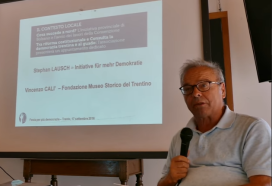 Intervento di Vincenzo Calì a “Una Festa per Più Democrazia” – Trento, 17 settembre 2016
Intervento di Vincenzo Calì a “Una Festa per Più Democrazia” – Trento, 17 settembre 2016
In un mondo sempre più interdipendente, che procede all’integrazione alla velocità della luce, grazie alle nuove tecnologie, la salvaguardia della propria identità, senza indulgere ad alcuna nostalgia verso il buon tempo antico, assume un rilievo assoluto.
Dolomiti patrimonio dell’umanità: chi deve vigilare affinchè un bene comune dalle cui sorgenti trae alimento un intero Continente venga salvaguardato, se non la comunità che vive ai suoi piedi? Sottrarre ad essa la gestione delle risorse naturali “per interesse nazionale” (un varco che la riforma costituzionale in discussione renderebbe possibile) va nel senso di favorire la partecipazione popolare?
Urge, per una più sicura gestione del territorio, ridare voce attraverso regole condivise alle “illecite combriccole di popolo” che furono soppresse dall’Austria imperiale agli inizi dell’ottocento, se vogliamo porre un freno alla politica di rapina delle risorse naturali in atto.
La riscossa (l’immagine femminile di Caterina Lanz!) come da secoli, vede in prima fila le popolazioni ladine schiacciate alternativamente dai due gruppi nazionali prevalenti: la regione dolomitica è il traguardo da raggiungere.
Mezzo secolo fa l’Europa dei popoli traeva linfa dalla contestazione studentesca, con la parola d’ordine lanciata da Parigi: l’immaginazione al potere. Ai giovani di oggi si chiede di prendere in mano il loro futuro, di fare proprio lo slogan scolpito nella pietra del Dos Trento, dichiarando, rovesciando il detto latino, che per loro non esiste l’impossibile. Noi siamo qui ad incoraggiarli e sostenerli.
Sull’immaginare il futuro si gioca oggi la vera sfida per un’Europa unita che, oggi come oggi, rischia di morire nella culla. Per noi il futuro vuol dire una regione europea alpina, tre comunità, la ladina, la tedesca e l’italiana, che si autogestiscono, con la massima apertura ai profughi dalle guerre da parte di una terra che ha conosciuto il dolore della lontananza dal patrio suolo.
La solidarietà verso i più deboli, il soccorso a vicini e lontani in caso di calamità, devono continuare ad essere il portato della specialità autonomistica di queste terre tra i monti, che hanno saputo produrre profeti ieri (Fra Dolcino e Margherita) e oggi ( Alexander Langer).
Europei prima che italiani, ladini, tedeschi: la civiltà occidentale vive solo se si radica in noi il concetto di cittadinanza europea, al di fuori della quale non vi è salvezza per nessuno: gli immensi problemi a cui i dannati della terra ci richiamano non si fermano sulle sponde del Mediterraneo ma richiedono per la loro soluzione l’impegno corale di un Continente intero.
Le genti alpine hanno contrastato, nella loro storia, la concentrazione dei poteri in poche mani, che fossero quelle di un Principe, di un Vescovo di un Imperatore o di un Podestà; il ricorso alla democrazia diretta, deve, come nella migliore tradizione locale, tornare ad essere la stella polare a cui guardare se vogliamo raggiungere l’obbiettivo della salvaguardia del bene comune.
Da ciascuno il suo: noi partiamo dal nostro campanile, da Trento, piccola capitale alpina, che nella sua bimillenaria storia ha conosciuto sconfitte e vittorie, della cui esperienza possiamo fare tesoro per un nuovo protagonismo che ci veda presenti e attivi ben oltre la corona dei monti che ci circondano, scrollandoci di dosso il severo giudizio sulla città del riformista illuminato Carlo Antonio Pilati che ancora per certi versi grava su di noi.
* * * * *
IL FEDERALISMO POSSIBILE: UNA REGIONE EUROPEA NELLE ALPI CENTRALI
di Vincenzo Calì
Paolo Prodi, nel recentissimo libro prodotto insieme a Massimo Cacciari (Occidente senza utopie, Il Mulino) così termina il saggio in cui si interroga riguardo la possibilità di porre un freno al declino della civiltà occidentale: “ lo storico deve terminare con un punto interrogativo: l’approfondimento va lasciato ai teologi”. Il fatto che le scienze religiose a Trento non godano di buona salute, come Paolo Ghezzi ha chiaramente messo in evidenza, e che le scienze storiche vivano una condizione analoga, non lascia ben sperare sul futuro del laboratorio trentino, l’unico che avrebbe potuto dare risposta alle urgenti domande del presente. Prodi e Rogger, sotto la guida politicamente illuminata di Bruno Kessler, avevano contribuito a far nascere negli anni settanta un centro studi ITC ora FBK che intendeva accettare la sfida leonardesca della ricomposizione dei saperi. Sfida persa,con istituti di ricerca anche fisicamente separati, fra pianura e collina (pensiamo cosa sarebbe stata, realizzando il disegno di Kessler, una città dei saperi nell’area industriale dismessa di Piedicasello). Se ISIG e ISR perdono la loro funzione di cerniera fra mondi fisicamente vicini ma intellettualmente lontani, viene meno anche la speranza di mantenere per Trento la vocazione all’autogoverno, storicamente punto di forza delle genti alpine. Le cerimonie del 5 settembre 2016 a Trento e Bolzano per i 70 anni dell’accordo Degasperi-Gruber hanno messo in tutta evidenza l’esigenza di por fine ad una stagione, quella in cui la potestà autonomistica derivava da concessioni dall’alto (potenze vincitrici, governi italiano ed austriaco, unione europea) più che da un moto di popolo, manifestatosi, e in tempi diversi, solo con l’ adunata dell’ASAR a Trento e della SVP a Castelfirmiano. Ricondotto alla sua essenza infatti, l’accordo italo-austriaco era inteso a salvaguardare i diritti delle minoranze sul territorio dell’attuale provincia di Bolzano, della quale nel 1946 non facevano parte i comuni della bassa atesina, e quindi non può essere richiamato a fondamento di un’autonomia, quella trentina, che ha ben altre e più antiche origini, chiaramente definite da Cesare Battisti nella sua monografia sul Trentino del 1898: “I liberi ordinamenti, che trento ebbe dai primissimi tempi, erano ottimo mezzo allo svolgersi della lingua, alla conservazione delle tradizioni nazionali; il dualismo politico fra l’autorità vescovile e la municipale, che informò gran parte della vita del Trentino, impedì sempre il prevalere del Principato..”. E sulla centralità della questione ladina, asse portante della regione alpina dolomitica, è ancora Battisti che ci ricorda come a metà ottocento sommando le aree ladine pure e miste si veniva a coprire un terzo del territorio complessivo delle attuali provincie di Trento,Bolzano e Belluno. Le legittime richieste di autogoverno delle popolazioni ladine, frustrate nel primo e nel secondo dopoguerra, rappresentano tuttora il punto di partenza per la costruzione di una regione europea alpina che si estenda dai Grigioni al Friuli e che non sia sottoposta alla servitù delle capitali di pianura. Premesso che una storiografia condivisa ed inclusiva non potrà che essere il prodotto di un processo di ridefinizione dell’autonomia, da uno sguardo alla storiografia sedimentatasi in questi settant’anni si possono trarre spunti di riflessione. Franco Demarchi, nel suo “Sociologia di una regione alpina” che diede alle stampe nel fatidico 1968, a cavallo fra primo e secondo statuto di autonomia, indicò alcuni indirizzi per “ridare un’anima all’autonomia” Come ha sottolineato Antonio Scaglia, la questione autonomistica si pose allora in questi termini: “Il fenomeno della manipolazione ideologica della società e della cultura alpina periferica da parte della cultura e del potere urbano viene illustrato scientificamente dalla preoccupazione pianificatoria degli anni sessanta in Italia da F. Demarchi quando, a fronte del degrado e della crescente marginalità delle periferie delle comunità alpine del Trentino e del Nord Italia, attingendo soprattutto a studi condotti in Svizzera, propone un modello che si incentra su due cardini: la riorganizzazione dei trasporti, la creazione di centri funzionali di servizi per raggiungere i quali non si vada al di là della mezz’ora. Il fenomeno di degrado demografico, economico, della rete dei servizi del Trentino andava, secondo F. Demarchi, riorganizzato secondo un modello funzionale ma anche sociale delle aree intermedie. Ma la osservazione più centrata di questo studio, al quale fa seguito l’ipotesi del comprensorio di O. Samonà è che la periferia si trova sguarnita di leadership intellettuale, politica e di animazione e gestione dello sviluppo”. Oggi, a distanza di mezzo secolo, a fronte di una nuova marginalità derivante dai ritardi accumulati nell’infrastrutturazione del territorio (banda larga, rete ferroviaria, mobilità verticale, rete dei servizi per le comunità di valle) e all’emergere di una forte concorrenzialità delle aree pedemontane lombardo-venete con il Trentino, diventa ineludibile uscire dalla sindrome “Trentino isola dorata”; come sempre Scaglia osserva, “la corretta procedura conoscitiva e l’elaborazione di una strategia di sviluppo autonomo della realtà montanaro-alpina consiste nel procurarsi una conoscenza adeguata del suo sistema sociale, antropologico e culturale e della sua interconnessione con il sistema urbano e di mercato, per poter evidenziare le sue reali potenzialità autodecisionali, per farla uscire concretamente dallo stato di dipendenza ideologica e non per astrarla utopisticamente dalla propria realtà.” A poco possono valere le rivendicazioni in chiave storica di una specialità autonomistica, che pur avendo una loro giustificazione (vedi i saggi relativi a Trentino e Sudtirolo in Schiera P., Gubert R., Balboni E., L’autonomia e l’amministrazione locale nell’area alpina, Jaca Book Ed. Universitarie, Milano 1988.) poco ci possono dire riguardo gli sviluppi futuri nel quadro di una globalizzazione di dimensioni epocali come quella in atto. La manipolazione politica a cui è stato per decenni sottoposto il popolo trentino (l’autonomia come autosufficienza) non crea le condizioni migliori per l’avvio di una nuova offensiva autonomisica che contrasti l’accentramento statale e il venir meno di un quadro certo di riferimento nelle istituzioni europee.
Di fonte alle nuove minoranze che si vengono a creare con gli esodi biblici del Sud del mondo, alla aggressività del capitale finanziario, alla nuova realtà geopolitica mondiale e al rinchiudersi degli stati europei entro barriere nazionali, il compito dell’elaborazione di un terzo statuto come carta di un nuovo patto fra popolo trentino, Stato nazionale ed Europa esige una narrazione nuova, di impianto federalista. Tale obbiettivo per essere perseguibile deve avere come presupposto l’indicazione di un percorso futuro che superi le contrapposizioni ideologiche del passato, facendo chiarezza sul fatto che le divisioni di impianto nazionalistico dei due secoli alle nostre spalle, che vanno certo storicamente documentate (nessun abbraccio postumo fra Hofer, Battisti e Degasperi) non devono rappresentare un alibi per una mancata stesura della carta della convivenza, fatto questo che, se dovesse avvenire,sancirebbe la cancellazione del Trentino come realtà geopolitica. Renato Ballardini, autorevole esponente della generazione che ha provveduto a rendere operativo l’impianto autonomistico, afferma oggi (“Il Trentino” del 7 settembre 2016) che per uscire dalla crisi in atto “La soluzione è in un Europa federale, con un tesoro ed un patrimonio unico, che assorba i debiti dei singoli stati, che li risani con un sistema fiscale equo ed efficiente”. Può un simile processo prendere forma senza una convinta adesione popolare? E’ ancora Ballardini che ci rammenta che la madre di tutte le battaglie è quella contro un potere accentrato in poche mani: “una realtà occulta che va smascherata e che costituisce la vera fonte delle risorse necessarie per risanare i debiti pubblici e per finanziare le iniziative economiche volte a curare un mondo in cui l’enorme ricchezza già esistente sia più equamente distribuita. “Ha ancora un senso, in tale contesto, la difesa della specialità autonomistica delle due Provincie di Trento e Bolzano? La risposta è affermativa, in quanto un impiano federale per definizione poggia sulle basi di governi territoriali solidi ed orgogliosi della propria identità. Quella che va costruita, con una paziente opera di coinvolgimento dei meno abbienti, è una realtà di movimento democratico di cui oggi avvertiamo l’assenza. A quanti a vario titolo sono preposti a disegnare il percorso verso il terzo statuto di autonomia di una regione in cui i gruppi linguistici vivono da separati in casa, il contesto nazionale ed europeo vive forti spinte centralistiche e la crisi economica colpisce i più deboli, i suggerimenti per un ordinamento regionale del rivoluzionario Michael Gaismair, vecchi di cinque secoli, potrebbero ancora dire qualcosa, a cominciare dall’incipit: “innanzitutto dovete promettere e giurare di mettere insieme vita e beni, di non dividervi l’un l’altro, ma di sopportare insieme vantaggi e svantaggi, di agire dopo esservi consultati fra voi.. tutti i privilegi devono essere aboliti… nessuno deve essere avvantaggiato rispetto ad altri”. Proseguendo nella lettura della Landesordnung di Gaismair, nell’ottima traduzione che ne fece Hildegard Eilert nel 1988, leggiamo che per abbattere i costi si propongono poche comunità territoriali con poteri giurisdizionali. Dati i tempi nuovi (in mezzo millennio molta acqua è passata sotto i ponti dell’Adige) si potrà discutere sull’attualità della proposta di fare di Bressanone la sede del governo e dell’Università del Land e di Trento il luogo in cui organizzare “le arti e i mestieri” ma non certo sul fatto di entrare nel merito delle questioni che toccano la vita quotidiana. La storia può venire quindi in aiuto: Merano fu la capitale morale del moto rivoluzionario più significativo dell’età moderna, luogo in cui la dieta contadina si riunì nel 1525 per stendere i 64 articoli considerati dalla storiografia il punto più avanzato sul fronte meridionale della guerra dei contadini (segnalo, dalla vastissima bibliografia, gli atti del comitato di contatto per l’altro Tirolo del 1982 e la sintesi “Da Muntzer a Gaismair”di Italo Michele Battafarano del 1979). Oggi, le ragioni dello stare insieme, la molla che mosse allora il popolo, non sono venute meno, sono solo entrate in una scala diversa, quella del contesto globale. Dopo un 5 settembre da separati in casa (Trento con la Consulta su di un binario morto, Bozen chiusa in un Konvent in stato d’assedio da parte dei gruppi isolazionisti) ci rimane Merano, con l’iniziativa della memoria storica a Castel Tirolo e con l’attualizzazione hoferiana di San Leonardo in Passiria.
Se il “Frame” entro cui si vince o si perde in termini di civiltà, come sottolineato da Ballardini, è l’Europa, i popoli devono riappropriarsi della sovranità, non delegandola più a rappresentanze delegittimate; esercitando quella democrazia diretta che sola permetterà la ripresa. La rivoluzione dell’uomo comune renderà possibile ciò che oggi non è in agenda: dare gambe all’utopia, qui rappresentata dalla libera regione dolomitica, possibile risposta al quesito posto da Massimo Cacciari : “L’utopia è fattore determinante del pensiero che ha informato di sè l’attuale “vittorioso capitalismo”, così come trasformandosi, o anzi capovolgendo il proprio segno,è fattore determinante delle forze reali che l’hanno combattuto o hanno creduto di combatterlo. Il primo non ne ha più bisogno,- e le seconde? Esistono ancora? E se esistono in quali forme si esprimono? E se non esistono o neppure esse possono più venire localizzate come e dove esercitare un pensiero critico?” Per rispondere a Cacciari, possiamo immaginare che politiche comuni fra i diversi ambiti territoriali della Regione alpina riguardo scelte strategiche (energia, comunicazioni, salvaguardia ambientale) potranno trovare nella tradizione storica, fatta di statuti, regole, pratiche democratiche, i punti di forza per contrastare le spinte neocentralistiche in atto in tutta Europa e in Italia in particolare. In un tempo in cui si pensa di alzare muri, la risposta democratica è una sola: raccogliere firme per chiedere che nasca quell’Europa federale entro la quale abbia diritto di cittadinanza una vera regione alpina transfrontaliera aperta ai vicini dell’Est e dell’ovest e i cui termini, a Nord e a Sud del Brennero, siano posti là dove i monti muoiono nelle pianure. Partiamo allora da Merano, il cuore storico delle Alpi, visto che al declino degli Istituti di ricerca trentini (ISIG-ISR) pare non sia possibile porre rimedio,e diamo vita ad un centro studi dall’alto valore simbolico ( magari intestato ad Alexander Langer), in cui assieme, tutti i gruppi linguistici pensino a disegnare gli scenari futuri; nel nome del leader sudtirolese, credo tanti sarebbero disposti ad impegnarsi e a mettere a disposizione il proprio patrimonio documentario e le proprie energie, al fine di richiamare in vita la regione dolomitica, istituto principe di una convivenza che, come disse Piero Agostini, non può essere nuovamente “rinviata”, specie in tempi di avventurose modifiche costituzionali.

Pingback: Riforma della politica e rivitalizzazione della democrazia | Più Democrazia in Trentino